|
Mirone
Scultore greco nativo di Eleutere in Beozia, è stato attivo ad
Atene tra il 470 e il 440 a.C. È lo scultore che segna il passaggio
dallo stile severo al primo classicismo. A lui venivano attribuite dalle
fonti antiche un notevole numero di opere in bronzo, oggi purtroppo tutte
disperse e a noi ignote. Solo tre opere delle sua produzione ci sono note,
non attraverso gli originali, ma grazie alle copie in marmo di epoca romana.
Si tratta del "Discobolo", del gruppo di "Atena e Marsia"
e di un "Anadoumenos", atleta che si cinge il capo con una benda.
Il Discobolo
è sicuramente l'opera più nota di Mirone, nonché,
data la sua fama, quasi un'icona dell'arte classica greca. Nella sua immagine
si cristallizzano alcune delle nostre maggiori suggestioni legate all'antica
Grecia: la passione per i giochi olimpici, il culto della perfezione del
corpo umano, la calma interiore che dialoga direttamente con l'eternità.
Il limite, e il tratto più arcaico, di Mirone è dato dalla
sua eccessiva fissità che contraddice la sua ricerca più
nota: quella sul movimento. Benché le sue sculture, soprattutto
nel Discobolo, cercano la rappresentazione del movimento, la sensazione
che trasmettono è di una immobilità statuaria che smorza
la potenzialità dell'atto che vogliono rappresentare.
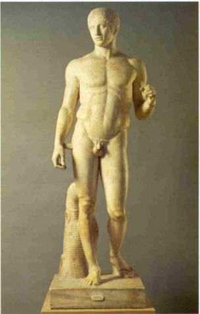 Policleto Policleto
Scultore greco nativo di Argo, Policleto è di poco più giovane
di Mirone, e come lui svolge un ruolo fondamentale per la nascita della
grande scultura classica. Il suo periodo di attività si colloca
all'incirca tra il 450 e il 420 a.C. Le sue opere erano quasi tutte realizzate
in bronzo, i cui originali ci sono purtroppo ignoti.
Della cospicua produzione di Policleto ci rimangono principalmente due
opere, note attraverso le copie: il "Doriforo" e il "Diadúmeno".
Sono entrambe due opere emblematiche del gusto estetico greco: perfezione
formale, senso dell'armonia e delle proporzioni, figure che nell'assenza
di turbamenti psicologici rivelano una dialogo con l'assoluto e l'eterno
che è uno dei motivi dell'intramontabile fascino di queste opere
d'arte.
Il Doriforo è una statua che, come il nome ci indica, ritrae un
atleta con un giavellotto in mano. Il corpo è attentamente studiato,
non tanto nelle sue particolarità anatomiche, ma soprattutto nelle
sue misure. Ciò a cui tende Policleto è un corpo perfetto
nel suo insieme: ogni singola parte sta al tutto come avverrebbe in un
reale corpo umano, idealmente perfetto. In pratica la sua ricerca di perfezione
è proprio nel dialogo e nel confronto tra reale e ideale. Reale
è la base di partenza: i rapporti alla base del suo canone sono
rilevati da reali misure effettuate sui corpi umani; ideale è l'effetto
a cui tende: scartando ogni difetto che, seppur minimo, è sempre
presente in ogni singolo individuo, la statua diviene un ideale di perfezione
umana superiore alla realtà stessa.
L'equilibrio raggiunto da Policlèto, detto ponderazione, è
un equilibrio stabile, ottenuto con un gioco sapiente di rapporti; perciò
immutabile: cambiare la posizione, anche di una sola delle parti del corpo,
significherebbe cambiare, contemporaneamente, tutte le altre, fino a raggiungere
un nuovo equilibrio. Questa statua rappresenta l'ideale greco di coerenza
razionale, ossia l'ideale di perfetta proporzionalità.
Bronzi di Riace
 Le
due sculture furono ritrovate nel mare Ionio, a 300 metri dalle coste
di Riace in provincia di Reggio Calabria, nel 1972. L'eccezionalità
del ritrovamento fu subito chiara, date le poche statue originali che
ci sono giunte dalla Grecia. Le
due sculture furono ritrovate nel mare Ionio, a 300 metri dalle coste
di Riace in provincia di Reggio Calabria, nel 1972. L'eccezionalità
del ritrovamento fu subito chiara, date le poche statue originali che
ci sono giunte dalla Grecia.
L'analisi stilistica e quella scientifica sui materiali e le tecniche
di fusione hanno entrambe determinato la differenza sostanziale tra le
due statue: sono da attribuirsi a due differenti artisti e a due epoche
distinte. L'attribuzione odierna, in base ai confronti stilistici oggi
possibili, è di datare la "statua A" al 460 a.C., in
periodo severo; mentre al periodo classico, e più precisamente
al 430 circa a.C., viene datata la "statua B".
Si tratta di determinazioni che possono ancora essere modificate, anche
perché sappiamo davvero pochissimo di queste due statue. Ignoti
sono sia gli autori, sia i personaggi raffigurati, sia la collocazione
che avevano nell'antichità. Al momento possiamo solo ritenere che
si tratti genericamente di due atleti o di due guerrieri, raffigurati
come simbolo di vittoria.
Le statue furono con probabilità realizzate ad Atene e da lì
furono rimosse per essere portate a Roma, forse destinate alla casa di
qualche ricco patrizio. Ma il battello che le trasportava dovette affondare
e il prezioso carico finì sommerso dalla sabbia a circa 8 metri
di profondità.
Risposte
1. b
2. c
3. a
|
